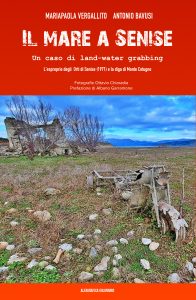 Un caso di land-water grabbing in Basilicata (XX sec.)
Un caso di land-water grabbing in Basilicata (XX sec.)
L’esproprio degli antichi orti di Senise (1971) e la diga di Monte Cotugno
Creative Commons Attribuzione citando la fonte
* E’ possibile richiedere informazioni sul testo al seguente indirizzo: https://www.pandosia.org/contatta-pandosia/
* Il fenomeno del land grabbing, ovvero l’accaparramento delle terre, e la sua variante water grabbing, ossia l’acquisizione di risorse idriche, rappresentano dinamiche complesse di natura economica e geopolitica. Tali processi implicano l’acquisizione di terra e acqua, spesso localizzate in regioni in via di sviluppo, portando profonde ripercussioni strutturali che non si limitano al contesto locale. Questi cambiamenti alterano in modo significativo gli equilibri sociali ed economici, minacciando sia la sussistenza che il benessere delle popolazioni coinvolte. La progressiva privatizzazione dei beni comuni rischia di escludere le comunità dalla gestione diretta delle risorse essenziali, trasformandoli in strumenti di profitto a scapito della collettività. Affrontare questa emergente problematica richiede un approccio che tuteli i beni comuni, considerandoli non come proprietà privata o esclusiva del potere statale, ma piuttosto come diritti inalienabili e fondamentali per il benessere collettivo. In questo contesto si colloca l’analisi proposta da Mariapaola Vergallito e Antonio Bavusi, accompagnata dagli scatti fotografici di Ottavio Chiaradia e introdotta dalla prefazione di Albano Garramone. L’opera esplora il processo che, tra gli anni Settanta e Ottanta, ha portato alla costruzione della più grande diga in terra battuta d’Europa, situata presso Monte Cotugno, nel comune di Senise, in Basilicata (provincia di Potenza). Attraverso un‘indagine accurata, il testo ricostruisce la storia degli antichi e fertili “Orti di Senise,” un tempo fonte di ricchezza locale fino al loro esproprio. Vengono messi in luce i conflitti che hanno accompagnato la realizzazione della diga: dalle lotte dei contadini contro il progetto alle richieste di compensazione avanzate dalle comunità locali. Il “Mare a Senise” esplora il tema delle resistenze emerse a partire dagli anni Ottanta e le problematiche attuali legate al mancato sviluppo di questa area interna della Basilicata. L’opera offre un‘analisi incisiva delle dinamiche di marginalizzazione connesse alla gestione delle risorse idriche, evidenziando la transizione verso un utilizzo sempre più privatizzato dell’acqua e delle infrastrutture necessarie per il suo accumulo e trasporto. Tuttavia, tali infrastrutture restano ancora lontane dall‘essere adeguate per affrontare le sfide cruciali poste dai cambiamenti climatici.
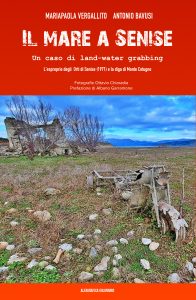 Un caso di land-water grabbing in Basilicata (XX sec.)
Un caso di land-water grabbing in Basilicata (XX sec.)