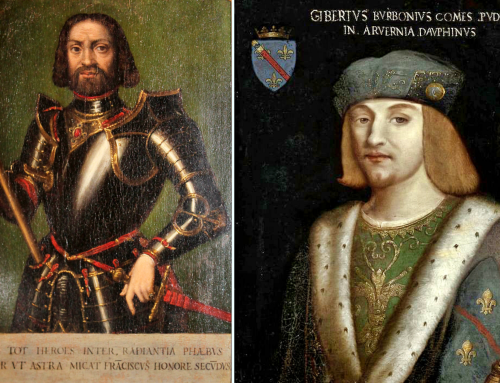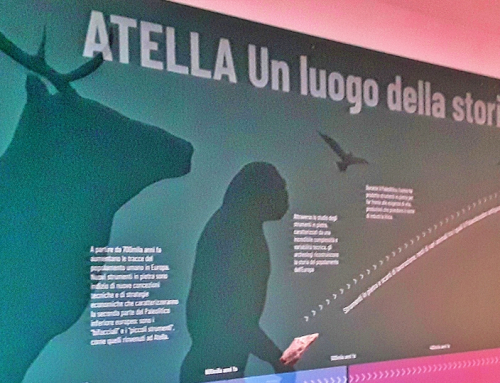di Antonio Bavusi – geoitinerario Vito l’Erario (Giugno 2023)
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale citando la fonte
Scarica l’eBook gratuito (in formato pdf)
 Lungo questa strada si possono riscoprire storie dimenticate (qualche volta volutamente oscurate), anche da chi vive nei paesi che la strada attraversa. La Strada Regia di Basilicata, oggi abbandonata dalle grandi reti di comunicazione, è stata infatti sostituita negli anni Sessanta del secolo scorso da autostrade che seguono i letti dei fiumi nelle valli, assecondando la velocità delle automobili, che hanno preso il posto delle carrozze, dei cavalli, dei carri e dei muli.
Lungo questa strada si possono riscoprire storie dimenticate (qualche volta volutamente oscurate), anche da chi vive nei paesi che la strada attraversa. La Strada Regia di Basilicata, oggi abbandonata dalle grandi reti di comunicazione, è stata infatti sostituita negli anni Sessanta del secolo scorso da autostrade che seguono i letti dei fiumi nelle valli, assecondando la velocità delle automobili, che hanno preso il posto delle carrozze, dei cavalli, dei carri e dei muli. Venne denominata “Ferdinanda” da alcune municipalità dell’ex Principato Citra, in onore del re di Sicilia. Voluta per rompere un isolamento di una terra attraversata da viaggiatori che raggiungevano le città di opposti mari, seguiva in parallelo antichi e disagevoli tratturi delle serre dei monti, utilizzati in passato dai popoli oschi durante le transumanze verso le marine e che collegavano fra loro cinte fortificate inaccessibili e paesi arrocati sui monti, tra foreste e imprevisti deserti di argilla.
La Strada Regia di Basilicata, abbandonati gli antichi tratturi delle serre (la Via degli Stranieri collegava lo Ionio al Tirreno seguendo le serre dei monti da Metaponto a Poseidonia), attraversava invece le pendici delle montagne, seguendone le curve di livello. Superava fiumi e torrenti con arditi ponti e ponticelli in pietra o in legno, spesso distrutti dalle piene.
Questo territorio conserva ancora grandi contraddizioni, con paesaggi naturali e storici che oggi vengono di sovente violentati. Dopo l’Unità d’italia iniziò un inesorabile spopolamento delle campagne dovuto alle morti per malattie, guerre ed emigrazione, con bassi indici di natalità che portarono povertà e miseria (le inchieste sociali condotte in alcuni comuni, quali quelle condotte a Grassano e Tricarico nel secolo scorso, evidenziarono questi fenomeni in maniera drammatica).
La storia millenaria è ancora quella legata alle consuetudini di una sorta di feudalesimo dei potenti, capace di impoverire i poveri ed arricchire sempre di più i ricchi, che prospera là dove è più forte l’ignoranza e l’immobilismo, confinando le coscienze e generando nuovi deserti culturali, umani e naturali, così come testimoniano le vicende, ancora attuali, dell’occupazione delle terre da parte dei contadini a cui seguì la Riforma fondiaria degli anni Cinquanta, con il fallimento dell’industrializzazione forzata nelle valli.